
da Monica Guerra | Ott 19, 2018 | notizie, recensioni
Da Laboratori Poesia un’intervista a cura di Michele Paoletti, si parla di ulla Soglia, del Festival di Poesia Tres Dotes, delle rassegne Poetry e Scontrosa Grazia.
qui il link.
Come nascono le tue poesie?
Indagare la realtà che ci circonda, attraverso i versi, è spesso l’atto finale di una qualche esperienza. La Poesia è uno scavo che l’uomo compie su se stesso e anche se l’atto finale accade dinanzi a un foglio bianco, inizia comunque molto tempo prima; con questo intendo che una poesia dovrebbe sempre possedere radici profonde, anche quando germoglia apparentemente in modo repentino. Ci sono poesie che richiedono un lungo tempo di sedimentazione e di limatura, ci sono testi che invece nascono in modo più fluido. Io lavoro molto per sottrazione, amo distillare. Il mio computer e i miei quaderni sono colmi di annotazioni e di poesie in lavorazione, sono pieni di embrioni di versi e forse pochi vedranno la luce.
Talvolta il processo di scrittura nasce da una parola che incontro “fortuitamente” durante la giornata, o durante il sonno, che si sposa con un pensiero, o con un sentimento, che se ne stava cheto nel sottofondo. Spesso, molto spesso, essendo una lettrice bulimica, la mia poesia nasce da altra poesia.
Quali sono i tuoi autori di riferimento, se ci sono, quelli a cui ritorni ogni volta che inizi a scrivere un nuovo libro?
Credo sia difficile per me identificare solo qualche autore di riferimento, tanto porosa è la poesia, almeno la mia, che assorbe qualcosa ogni dove, posso però nominarti gli autori che amo, in primis Paul Celan. Non torno a lui prima di scrivere un libro, torno a lui ogni volta in cui sento l’intimo bisogno di ascoltare i suoi versi e questo accade con una certa frequenza.
Amo molto anche Mandel’stam, Achmatova, Cvetaeva, amo Rilke, Borges e Pessoa, però fatico a non nominare Eliot. Guardando all’Italia invece il mio faro è sicuramente Ungaretti, per quanto ami anche Saba e tanti altri autori. In questo preciso momento sto lavorando su Amelia Rosselli e sono sopraffatta dalla sua potenza.
Con l’associazione IndependentPoetry da diversi anni organizzi a Faenza la rassegna #POETRY che è diventata un riferimento nel panorama culturale della città. Ci vuoi raccontare com’è nata? Qualche episodio che ricordi con piacere? Ci puoi anticipare qualcosa della nuova stagione?
L’associazione è nata per amore della Poesia e per il desiderio di condividerla. Talvolta l’incontro con un autore può accendere una passione che non si sapeva di nutrire; tanti sono i neofiti che si sono avvicinati ai nostri appuntamenti: alcuni sono capitati per caso e non hanno più smesso di frequentare. Ricordo, tra le tante belle situazioni createsi, momenti in cui nonni e nipoti si sono incontrati casualmente al POETRY!
La nuova rassegna sta per iniziare e sarà piena di novità. Dopo quarantun appuntamenti al bar Linus, quest’anno abbiamo programmato un calendario “diffuso” sul territorio.
Cinque luoghi ospiteranno circa diciassette serate, concepite proprio in base alla tipologia dello spazio che abbiamo a disposizione. Abbiamo in cantiere anche diversi laboratori per le scuole e alcune preziose collaborazioni. Ci sarà tanta poesia contemporanea ma anche conferenze e letture di grandi autori del passato. A brevissimo pubblicheremo il calendario definitivo sul sito www.independentpoetry.org e sulla pagina Facebook (Poetry Faenza).
Lo scorso giugno è nato il Festival Tres Dotes a Tredozio (FC). Un’importante manifestazione poetica che ha ospitato tra gli altri autori Maria Grazia Calandrone, Giovanna Rosadini, Gianfranco Lauretano e molti altri. Ce ne vuoi parlare?
Il Festival Tres Dotes, organizzato assieme ad Alessandro Canzian e finanziato dal Comune di Tredozio, è stato un bell’esempio di come turismo e cultura possano andare nella medesima direzione, nutrire gli animi ma anche le piccole economie locali. L’Italia è paese principe della poesia e dell’arte e credo che i nostri borghi dovrebbero essere pieni di manifestazioni di questa tipologia. Portare i grandi autori tra la gente, anche nei piccoli paesi, significa portare la poesia dove dovrebbe stare e non solo tra gli addetti ai lavori, significa abituare (o ri-abituare) le persone al pensiero, al sentimento e al potere della parola. Sinceramente il lavoro è stato ciclopico, e tu lo sai bene perché eri con noi, ma quando, sfiniti e infreddoliti, alle due di notte abbiamo trovato riparo per continuare a leggere i versi io, come molte altre persone, ho sentito scorrere davvero qualcosa di magico. Il festival di Poesia ha generato appartenenza, condivisione e solidarietà e questo è stato il bene più grande.
Parliamo adesso del tuo ultimo libro Sulla soglia (Samuele Editore, 2017), una sorta di cronologia di un addio ad un’amica scomparsa prematuramente. Ad un certo punto scrivi “è salvare, la necessità”, più avanti “se scrivo è per farti poesia”. Scrivere dunque per sopravvivere, per far sopravvivere.
Scrivere significa già salvare qualcosa, farlo sopravvivere all’oblio, agli ossequi della dimenticanza. Io sono stata impotente per tutto il decorso della malattia, sono stata inutile di fronte all’esito e così ho tentato di registrare ciò che accadeva. Misurare il silenzio, con la matita in mano, capendo che ognuno muore a suo modo, come può, intendo.
Ho trovato molto ardua la fase della pretesa e dell’illusione e scrivere mi era, in un certo modo, necessario per nominare cose e accadimenti con il loro nome, per ritornare alla realtà. Ho tentato di celebrare la vita, quella che era stata, quella che ancora era negli attimi della malattia e quella che dopo, comunque, sarebbe restata, nella sfera del ricordo.
La soglia è una dimensione a sé stante, un luogo in cui non si è né morti né completamente vivi. La soglia è un occhio frontale, l’impossibilità di pianificare e per quanto tutti viviamo, oggi giorno, della retorica del “qui e ora” solo in quel preciso momento, privati del futuro, sfioriamo il significato di questo luogo comune.
Sulla Soglia è un tentativo di celebrare l’amore “tenendosi per mano” al di là dalla questione mortale, per questo voglio continuare a celebrare, con le parole, quel sentimento dolce e autentico, come se il dialogo non si fosse interrotto, ma avesse solo cambiato canale.
Parlare di morte significa, oltre i luoghi comuni, celebrare la vita. Significa incastonare nei versi una forza vitale che pacifichi lo smarrimento e che consenta un reinventarsi radicale. Cos’è la vita, in fondo, se non un continuo reinventarsi?
Sulla soglia è un libro bilingue, scritto in italiano e inglese. Vuoi raccontarci qualcosa del percorso di traduzione?
Ho vissuto diversi anni a Los Angeles e la lingua inglese è inevitabilmente tornata in Italia con me. Mi trovavo in Texas mentre stavamo lavorando alla pubblicazione del libro ed è stato naturale cercare di accasare i versi anche in questo idioma. La traduzione è stata veloce ed efficace, anche se poi ho affidato al poeta e amico Patrick Williamson la sua supervisione.
Solitamente traduco dall’inglese all’italiano, ma trattandosi dei miei versi non ho avuto timori nel seguire il percorso contrario. Certo è che ogni traduzione è figlia di compromessi, penso ad esempio a un testo in cui l’italiano dice: stanare un tarlo e l’inglese non riesce a rendere lo stesso concetto se non tramite altre immagini. Tradurre significa indagare tutte le possibilità di senso, forse ancora più che scriverle, tradurre amplia i confini della parola ma talvolta rivela anche i suoi stessi limiti.
la voce cruda della vastità
punge sottopelle nell’aria umida
e una pacifica inquietudine
allaga la faglia del silenzio
com’è facile soli l’altro
occhio della luna il deserto
e com’è difficile al contempo
una pace distratta
fra dita di scoiattolo
e cemento, l’abbandono
è un verde selvatico
a presa rapida
una malinconia farfugliata
ma tu srotolale le ciglia
scompiglia i nidi vergini
sui seni tra i capelli
la verità freme libera
in una tana disabitata
Chateau Duval la strada ribolle
e questo sole scortica anche me
ma la fatica è una guado senza direzione
dove la terra beve ogni forma
in procinto di cadere
si scioglie nell’asfalto il passo
per l’eccesso d’esitazione
svivere scortica anche me
Le poesie sono tratte dalla silloge inedita Attese.

da Monica Guerra | Mar 15, 2018 | notizie, recensioni
Monica Guerra, Sulla soglia (On the threshold; traduzione di Monica Guerra e Patrick Williamson), Samuele editore, 2017
Su Poetarum Silva, a cura di Melania Panico. Leggi tutto cliccando qui.
Si resta sulla soglia per vari motivi. Si resta per guardare con occhio attento e quasi distante, tra il sospettoso e il pauroso.
Si resta per attendere una risposta, perché non ce la si fa a stare completamente dentro una situazione che fa male.
Si resta sulla soglia per segnare il confine tra questa e quella parte, tra noi e noi, quando il confine diventa un modo per riflettere anche su se stessi: ciò che siamo stati, ciò che non siamo più, ciò che siamo diventati.
Il libro di Monica Guerra è tutto questo. È un libro che riflette sulla questione del restare. Come se restare, il compito di chi resta, chi non va via, fosse una responsabilità. La responsabilità della vita: «la catena che non spezzo», nonostante tutto perché «morire è un’isola/ perché morire/ non è come dirlo».
Restare è anche una prova. Infatti il libro è un viaggio (anche cronologico) a ritroso, a ripercorrere il perché e il come del saluto (che è il titolo della prima sezione). Monica Guerra parla del tempo come ripetizione del gesto e in alcuni punti diventa esplicito il suo riferimento al “ciclico”: «morire è un gesto/a ripetizione […] la separazione non esiste».
Come a dire che nulla è definitivo, tranne l’amore come motore e pena, non soltanto ricordo ma stella fissa sempre splendente – quando effettivamente resta in alto come punto a cui guardare – per trovare una direzione. L’estrema sezione del libro si intitola proprio Il ricordo: tutto si è già compiuto, anche l’elaborazione della distanza, anche la fermezza e il commiato, la vita che non mi fa dormire e poi l’epilogo: «pensare che sondavo il morire/ dov’è ora il mare». Qualcosa che somiglia alla grandezza.
© Melania Panico
◊
6 Luglio 2016
la lacrima lungo l’angolo
sinistro il passaggio, ogni
giorno riscorre il tuo andare
nel mio occhio in prestito
che poi cosa vuoi che sia,
la vita non è tutto.
30 Maggio 2016
qui è un andare piano
invischiare la direzione
l’ombra lunga del cipresso
è il mio non sentire l’anello
la catena che non spezzo.
17 Maggio 2016
sfogliavamo insieme
le stelle una dozzina
di cieli stralunati tu smistavi
una costellazione
e poi d’un tratto
scorrere o il solco di un nonamore
la sorgente a rovescio
poggiasti il bicchiere
perché morire
morire è un’isola
perché morire
non è come dirlo.

da Monica Guerra | Feb 6, 2015 | notizie, recensioni
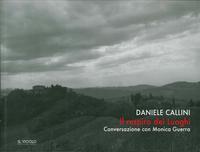 Dalla rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, una puntata dedicata a un breve estratto dal libro “Il respiro dei luoghi”.
Dalla rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, una puntata dedicata a un breve estratto dal libro “Il respiro dei luoghi”.
Daniele Callini, sociologo, e Monica Guerra, poetessa e imprenditrice, hanno intessuto un dialogo a partire da una domanda: cosa significano, per noi, i luoghi che abitiamo, o che attraversiamo viaggiando?
Monica – Abitiamo attimi che divengono pilastri su cui poggiare noi stessi.
Io ho abitato una casa senza confini, una casa i cui muri erano spalancati all’immensità della vita, le finestre affacciate sul davanzale del giorno e la mia immaginazione, gravida di sogni, spaziava senza barriere. Il mio animo cresceva leggero, senza timori, integrante e integrato in un disegno supremo. Poi ho abitato un labirinto oscuro, un corridoio angusto con una sola via d’uscita, senza ritorno, un appartamento fortificato per sigillare le vergogne e le fragilità umane da un resto del mondo cui non sentivo più di appartenere. Il mio animo rinsecchito si chiudeva, giorno dopo giorno, alla bellezza della vita. Con le gambe appoggiate su due pilastri opposti, finalmente, ho abitato me stessa.
Daniele – Cosa pensi dunque, dell’abitare?
Monica – Le case che abitiamo ci rimangono dentro. Tutte contribuiscono alla formazione del nostro io, divengono bagaglio, viaticum per procedere nel percorso. Alcune elargiscono doni d’amore, altre sottraggono forza, talvolta, sono accoglienze distratte. Tutte nel loro insieme divengono specchi della nostra identità mentre noi interagiamo con la loro sottile energia. Alcune però si ancorano nel Sé, più di altre.
Daniele – Cambiare casa è sempre stata, per me, un’esperienza faticosa. Col trasloco non ho trasportato solo arredi, stoviglie, vestiario, libri… ma anche l’intero contenitore e con questo tutti quelli che l’hanno preceduto, con i ricordi, i vissuti…
Monica – Nonostante una moltitudine di traslochi, le mie dimore fondamentali sono state quattro. La prima a Tredozio, la mia casa dell’infanzia, il nido in cui ho conosciuto l’esistenza del bene, compiendo quella fondamentale esperienza che nel futuro mi ha permesso di ritornare a esso. La seconda mi ha insegnato, nei suoi labirinti scuri, che spesso ci crediamo troppo forti per sopprimere il bisogno di scegliere, ma siamo troppo fragili per accettare le conseguenze delle nostre scelte. Ogni decisione che si rifrange nel vivere dei nostri cari, andrebbe ponderata conquistando la libertà dal nostro smisurato ego. Nella dimora della fragilità ho imparato che spesso le cose più preziose, all’improvviso, vanno in frantumi, talvolta persino per futili motivi. Imparare che nulla è per sempre fa parte del viaggio della vita, purtroppo è anche lezione che ci dissesta come un terremoto e àncora il luogo dove la si è appresa al secretum dell’individuo. La mia terza dimora, la casa degli orrori, è la casa della sopravvivenza. Dove regna la violenza e aleggia la morte, si pianta il seme per la rinascita. La mia quarta casa è esattamente come tutte le case che sono venute dopo, semplicemente un luogo d’accoglienza dei miei progetti di vita.
Daniele – Io, poi, mi sono chiesto più volte che cosa significa “sentirsi a casa”?
Credo sia importante rispondere a questa domanda. È come stilare un programma non solo di esplorazione di sé, ma addirittura di significato.
Sentirsi bene, dentro al proprio contenitore, nella propria pelle, nei ruoli sociali che si abitano. Nel territorio che abitualmente si frequenta. Da casa si parte e a casa si ritorna, ogni giorno. È un inizio da cui si comincia un camminamento. È una collocazione nel mondo.
“Sentirsi a casa” è un’espressione comune, di tutti i giorni. Nel linguaggio comune vuole dire trovarsi a proprio agio, tra le proprie sicurezze, nel covo, nel rifugio, nella tana, o, semplicemente, nel proprio ambiente domestico. Dove ogni sfumatura è qualcosa di stabile, di consueto, di rassicurante. A casa non ci si sente spaesati. Si può liberamente continuare con le proprie abitudini e finanche modificarle. L’abitazione è la stessa cosa (e radice) dell’abito. Indossare ed essere indossati. “Sentirsi a casa” è anche questo. Adattarsi ad essa e fare in modo che essa si adatti a noi. L’interazione e la sistemazione continua divengono esperienza abituale e abitudinaria (la radice è sempre la medesima, da “abitare”!).
Monica – In tutta franchezza ho sempre detestato le abitudini. Non vado mai a letto alla stessa ora, non so mai cosa mangerò per colazione e la mia quotidianità è uno sforzo potenzialmente teso al distinguere l’oggi dal ieri e dal domani. Non riesco nemmeno ad acquistare, in modo continuativo, prodotti alimentari sempre della stessa marca! Non so da dove derivi questa mia viscerale avversità nei confronti delle abitudini, ma creando un ponte tra abitare e abitudine ora mia spiego perché l’espressione “Sentirsi a casa” non mi è mai davvero appartenuta. Più che un sentirmi a casa, nella casa, mi sento molto a casa con me stessa.
Nelle mie dimore, invece, mi sono sempre percepita come in una sorta di confortevole transito: seduta su un’accogliente punta del divano.
Daniele – Una meravigliosa poesia dell’islandese Sigurdur Palsson ha un titolo eloquente: La mia casa. Qui la casa è un’evidente metafora dell’esistenza, contenitore ben più ampio dell’edificio domestico che è dimora abituale, e ben oltre suoi comodi accessori. L’accoglienza diviene esperienza di accomunamento, di incontro, di senso, ed è con essa e attraverso essa, che tutto prende forma e significato.
La mia casa
Non manca quasi niente
nella mia casa.
Quasi niente
Manca il comignolo
Ci si abitua
Mancano i muri
e i quadri sui muri
Pazienza
Non manca molto
nella mia casa
Manca il comignolo
Che per adesso non fuma
Mancano i muri
e le finestre
e la porta
Ma è accogliente, la mia casa
Prego
Accomodatevi
Non abbiate paura
Mangiamo qualcosa
Spezziamo il pane, un goccio di vino
Accendiamo il camino
Guardiamo
no, ammiriamo i quadri
sui muri
Prego
entrate dalla porta
o dalle finestre
se non dai muri.
Monica – Questa bellissima poesia è molto vicina al mio intendere la casa. La casa come finestra del cuore, come luogo di condivisione, ponte tra noi e il mondo. La bellezza più autentica della mia casa, di tutte le case che ho abitato, è sempre ciò che si ammira fuori dalle finestre. L’abitazione, nei nostri anni, sta divenendo sempre più un buco in cui segregarsi, allontanandosi da quel modello del passato in cui rappresentava lo spontaneo prosieguo della vita dei cortili, delle terrazze e persino delle finestre affacciate sulla via. Un tempo la casa pullulava di nipoti, nonni, bisnonni, fratelli, zii e cugini e sotto lo stesso tetto, ciascuno degli inquilini, condivideva molte esperienze significative del vivere, alcune dirette altre indirette, come la nascita, la crescita, la vecchiaia, la malattia e infine la morte. Vivere e morire, e tutto ciò che sta nel mezzo, era, in quel modo, naturalmente “normalizzato”.
Daniele – Scriveva anche Francis Bacon, qualche secolo fa: «Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate». Lo stesso vale per la vita, la più grande delle case, quella che tutti, indistintamente, abitano.
Monica – …credo che sentirsi a casa nella vita sia la più sublime delle imprese…
Daniele – Sentirsi a casa nel mondo, è invece il titolo in italiano dell’opera dell’antropologo John Tomlinson, [… che] analizza le modificazioni culturali indotte dalla globalizzazione. Una cultura globale unificata non esiste ancora. Tuttavia una cultura globalizzata è già presente nella trasformazione delle relazioni e delle identità dei luoghi che abitiamo. La deterritorializzazione è appunto la perdita del legame con la propria località, provocata dalla globalizzazione. Tuttavia questo fenomeno viene bilanciato da una forza opposta, la riterritorializzazione, che spinge gli individui a ricostruire una casa nella modernità globale, casomai recuperando anche elementi identitari connessi alle proprie radici. Il cosmopolita diviene allora capace di vivere contemporaneamente, “nel globale e nel locale”.
[…]
Monica – […].
In merito alla globalizzazione posso raccontarti la mia piccola esperienza. Dopo essere cresciuta in un paese della Romagna, mia amata Heimat, le cui sinuose colline verdi ammiccano al mio senso d’appartenenza, ho vissuto in molte città, in Italia e all’estero. In alcune per pochi anni, in altre per molti. In alcune per obbligo, in altre per mia volontà. Ad alcune sono rimasta intimamente legata e altre invece mi sono, oggi, poco più che indifferenti. Ma una volta deciso di avere famiglia e mettere al mondo dei figli, ho fatto ritorno alle mie radici; ho seguito il mio compagno che nutriva il desiderio di trasmettere ai posteri i valori autentici della nostra terra, anche se questi si sono ben integrati con gli svariati arricchimenti maturati altrove. Devo ammettere che le mie figlie, oggi, provano un grande amore anche per il mio piccolo paese d’origine nonostante le loro sporadiche frequentazioni. Le radici sono necessarie per mettere a frutto ciò che si apprende altrove; credo che per andare liberamente sia necessario avere un luogo cui fare ritorno.
Daniele – Prima si parlava di traslochi. I luoghi che abbiamo attraversato o abitato continueranno loro stessi ad abitarci sin quando saremo in vita. Essi ci seguiranno inesorabilmente come esperienza e come ricordo. Le loro immagini ci accompagneranno, risvegliando, nei momenti più inattesi, memorie assopite. Nuove visioni della realtà troveranno allora posto nella nostra coscienza. I frammenti dispersi per strada potranno così ricomporsi, ma mai completamente. Il vero sogno sarebbe quello di poter raggiungere la rappresentazione esaustiva e unitaria della nostra stessa esistenza, casomai ripercorrendo ogni luogo e ogni momento a ritroso, come per essere sicuri di portarne memoria. Ma sappiamo tuttavia, in cuor nostro, che possiamo solo ricostruire immagini sfuocate e parziali, sempre provvisorie. Allora tentiamo di riordinare i fotogrammi della vita spaziale nel raccoglitore temporale della nostra memoria, e appena riusciamo a creare anche solo un cortometraggio, ci pare di aver compiuto una miracolosa opera d’arte. Proviamo così a lasciare traccia dei luoghi che attraversiamo, per non disintegrare il percorso compiuto e, con esso, noi stessi.
Vedi articolo-intervista >>


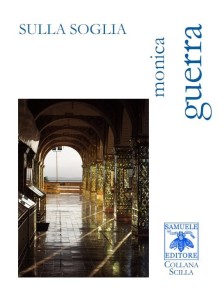 «Cos’è Sulla soglia? È il diario di bordo di un lungo salutarsi su una soglia che è una linea di confine, dell’illusione che possa andare tutto bene, di un happy ending che non c’è. Un raccontare, elaborare la perdita da parte di chi resta.
«Cos’è Sulla soglia? È il diario di bordo di un lungo salutarsi su una soglia che è una linea di confine, dell’illusione che possa andare tutto bene, di un happy ending che non c’è. Un raccontare, elaborare la perdita da parte di chi resta.


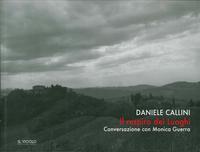 Dalla rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, una puntata dedicata a un breve estratto dal libro “Il respiro dei luoghi”.
Dalla rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, una puntata dedicata a un breve estratto dal libro “Il respiro dei luoghi”.