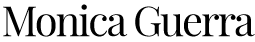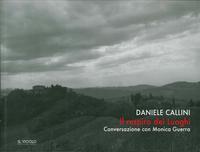 Dalla rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, una puntata dedicata a un breve estratto dal libro “Il respiro dei luoghi”.
Dalla rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, una puntata dedicata a un breve estratto dal libro “Il respiro dei luoghi”.
Daniele Callini, sociologo, e Monica Guerra, poetessa e imprenditrice, hanno intessuto un dialogo a partire da una domanda: cosa significano, per noi, i luoghi che abitiamo, o che attraversiamo viaggiando?
Monica - Abitiamo attimi che divengono pilastri su cui poggiare noi stessi.
Io ho abitato una casa senza confini, una casa i cui muri erano spalancati all’immensità della vita, le finestre affacciate sul davanzale del giorno e la mia immaginazione, gravida di sogni, spaziava senza barriere. Il mio animo cresceva leggero, senza timori, integrante e integrato in un disegno supremo. Poi ho abitato un labirinto oscuro, un corridoio angusto con una sola via d’uscita, senza ritorno, un appartamento fortificato per sigillare le vergogne e le fragilità umane da un resto del mondo cui non sentivo più di appartenere. Il mio animo rinsecchito si chiudeva, giorno dopo giorno, alla bellezza della vita. Con le gambe appoggiate su due pilastri opposti, finalmente, ho abitato me stessa.
Daniele - Cosa pensi dunque, dell’abitare?
Monica - Le case che abitiamo ci rimangono dentro. Tutte contribuiscono alla formazione del nostro io, divengono bagaglio, viaticum per procedere nel percorso. Alcune elargiscono doni d’amore, altre sottraggono forza, talvolta, sono accoglienze distratte. Tutte nel loro insieme divengono specchi della nostra identità mentre noi interagiamo con la loro sottile energia. Alcune però si ancorano nel Sé, più di altre.
Daniele - Cambiare casa è sempre stata, per me, un’esperienza faticosa. Col trasloco non ho trasportato solo arredi, stoviglie, vestiario, libri... ma anche l’intero contenitore e con questo tutti quelli che l’hanno preceduto, con i ricordi, i vissuti...
Monica - Nonostante una moltitudine di traslochi, le mie dimore fondamentali sono state quattro. La prima a Tredozio, la mia casa dell’infanzia, il nido in cui ho conosciuto l’esistenza del bene, compiendo quella fondamentale esperienza che nel futuro mi ha permesso di ritornare a esso. La seconda mi ha insegnato, nei suoi labirinti scuri, che spesso ci crediamo troppo forti per sopprimere il bisogno di scegliere, ma siamo troppo fragili per accettare le conseguenze delle nostre scelte. Ogni decisione che si rifrange nel vivere dei nostri cari, andrebbe ponderata conquistando la libertà dal nostro smisurato ego. Nella dimora della fragilità ho imparato che spesso le cose più preziose, all’improvviso, vanno in frantumi, talvolta persino per futili motivi. Imparare che nulla è per sempre fa parte del viaggio della vita, purtroppo è anche lezione che ci dissesta come un terremoto e àncora il luogo dove la si è appresa al secretum dell’individuo. La mia terza dimora, la casa degli orrori, è la casa della sopravvivenza. Dove regna la violenza e aleggia la morte, si pianta il seme per la rinascita. La mia quarta casa è esattamente come tutte le case che sono venute dopo, semplicemente un luogo d’accoglienza dei miei progetti di vita.
Daniele - Io, poi, mi sono chiesto più volte che cosa significa “sentirsi a casa”?
Credo sia importante rispondere a questa domanda. È come stilare un programma non solo di esplorazione di sé, ma addirittura di significato.
Sentirsi bene, dentro al proprio contenitore, nella propria pelle, nei ruoli sociali che si abitano. Nel territorio che abitualmente si frequenta. Da casa si parte e a casa si ritorna, ogni giorno. È un inizio da cui si comincia un camminamento. È una collocazione nel mondo.
“Sentirsi a casa” è un’espressione comune, di tutti i giorni. Nel linguaggio comune vuole dire trovarsi a proprio agio, tra le proprie sicurezze, nel covo, nel rifugio, nella tana, o, semplicemente, nel proprio ambiente domestico. Dove ogni sfumatura è qualcosa di stabile, di consueto, di rassicurante. A casa non ci si sente spaesati. Si può liberamente continuare con le proprie abitudini e finanche modificarle. L’abitazione è la stessa cosa (e radice) dell’abito. Indossare ed essere indossati. “Sentirsi a casa” è anche questo. Adattarsi ad essa e fare in modo che essa si adatti a noi. L’interazione e la sistemazione continua divengono esperienza abituale e abitudinaria (la radice è sempre la medesima, da “abitare”!).
Monica - In tutta franchezza ho sempre detestato le abitudini. Non vado mai a letto alla stessa ora, non so mai cosa mangerò per colazione e la mia quotidianità è uno sforzo potenzialmente teso al distinguere l’oggi dal ieri e dal domani. Non riesco nemmeno ad acquistare, in modo continuativo, prodotti alimentari sempre della stessa marca! Non so da dove derivi questa mia viscerale avversità nei confronti delle abitudini, ma creando un ponte tra abitare e abitudine ora mia spiego perché l’espressione “Sentirsi a casa” non mi è mai davvero appartenuta. Più che un sentirmi a casa, nella casa, mi sento molto a casa con me stessa.
Nelle mie dimore, invece, mi sono sempre percepita come in una sorta di confortevole transito: seduta su un’accogliente punta del divano.
Daniele - Una meravigliosa poesia dell’islandese Sigurdur Palsson ha un titolo eloquente: La mia casa. Qui la casa è un’evidente metafora dell’esistenza, contenitore ben più ampio dell’edificio domestico che è dimora abituale, e ben oltre suoi comodi accessori. L’accoglienza diviene esperienza di accomunamento, di incontro, di senso, ed è con essa e attraverso essa, che tutto prende forma e significato.
La mia casa
Non manca quasi niente
nella mia casa.
Quasi niente
Manca il comignolo
Ci si abitua
Mancano i muri
e i quadri sui muri
Pazienza
Non manca molto
nella mia casa
Manca il comignolo
Che per adesso non fuma
Mancano i muri
e le finestre
e la porta
Ma è accogliente, la mia casa
Prego
Accomodatevi
Non abbiate paura
Mangiamo qualcosa
Spezziamo il pane, un goccio di vino
Accendiamo il camino
Guardiamo
no, ammiriamo i quadri
sui muri
Prego
entrate dalla porta
o dalle finestre
se non dai muri.
Monica - Questa bellissima poesia è molto vicina al mio intendere la casa. La casa come finestra del cuore, come luogo di condivisione, ponte tra noi e il mondo. La bellezza più autentica della mia casa, di tutte le case che ho abitato, è sempre ciò che si ammira fuori dalle finestre. L’abitazione, nei nostri anni, sta divenendo sempre più un buco in cui segregarsi, allontanandosi da quel modello del passato in cui rappresentava lo spontaneo prosieguo della vita dei cortili, delle terrazze e persino delle finestre affacciate sulla via. Un tempo la casa pullulava di nipoti, nonni, bisnonni, fratelli, zii e cugini e sotto lo stesso tetto, ciascuno degli inquilini, condivideva molte esperienze significative del vivere, alcune dirette altre indirette, come la nascita, la crescita, la vecchiaia, la malattia e infine la morte. Vivere e morire, e tutto ciò che sta nel mezzo, era, in quel modo, naturalmente “normalizzato”.
Daniele - Scriveva anche Francis Bacon, qualche secolo fa: «Le case sono fatte per viverci, non per essere guardate». Lo stesso vale per la vita, la più grande delle case, quella che tutti, indistintamente, abitano.
Monica - ...credo che sentirsi a casa nella vita sia la più sublime delle imprese...
Daniele - Sentirsi a casa nel mondo, è invece il titolo in italiano dell’opera dell’antropologo John Tomlinson, [... che] analizza le modificazioni culturali indotte dalla globalizzazione. Una cultura globale unificata non esiste ancora. Tuttavia una cultura globalizzata è già presente nella trasformazione delle relazioni e delle identità dei luoghi che abitiamo. La deterritorializzazione è appunto la perdita del legame con la propria località, provocata dalla globalizzazione. Tuttavia questo fenomeno viene bilanciato da una forza opposta, la riterritorializzazione, che spinge gli individui a ricostruire una casa nella modernità globale, casomai recuperando anche elementi identitari connessi alle proprie radici. Il cosmopolita diviene allora capace di vivere contemporaneamente, “nel globale e nel locale”.
[...]
Monica - [...].
In merito alla globalizzazione posso raccontarti la mia piccola esperienza. Dopo essere cresciuta in un paese della Romagna, mia amata Heimat, le cui sinuose colline verdi ammiccano al mio senso d’appartenenza, ho vissuto in molte città, in Italia e all’estero. In alcune per pochi anni, in altre per molti. In alcune per obbligo, in altre per mia volontà. Ad alcune sono rimasta intimamente legata e altre invece mi sono, oggi, poco più che indifferenti. Ma una volta deciso di avere famiglia e mettere al mondo dei figli, ho fatto ritorno alle mie radici; ho seguito il mio compagno che nutriva il desiderio di trasmettere ai posteri i valori autentici della nostra terra, anche se questi si sono ben integrati con gli svariati arricchimenti maturati altrove. Devo ammettere che le mie figlie, oggi, provano un grande amore anche per il mio piccolo paese d’origine nonostante le loro sporadiche frequentazioni. Le radici sono necessarie per mettere a frutto ciò che si apprende altrove; credo che per andare liberamente sia necessario avere un luogo cui fare ritorno.
Daniele - Prima si parlava di traslochi. I luoghi che abbiamo attraversato o abitato continueranno loro stessi ad abitarci sin quando saremo in vita. Essi ci seguiranno inesorabilmente come esperienza e come ricordo. Le loro immagini ci accompagneranno, risvegliando, nei momenti più inattesi, memorie assopite. Nuove visioni della realtà troveranno allora posto nella nostra coscienza. I frammenti dispersi per strada potranno così ricomporsi, ma mai completamente. Il vero sogno sarebbe quello di poter raggiungere la rappresentazione esaustiva e unitaria della nostra stessa esistenza, casomai ripercorrendo ogni luogo e ogni momento a ritroso, come per essere sicuri di portarne memoria. Ma sappiamo tuttavia, in cuor nostro, che possiamo solo ricostruire immagini sfuocate e parziali, sempre provvisorie. Allora tentiamo di riordinare i fotogrammi della vita spaziale nel raccoglitore temporale della nostra memoria, e appena riusciamo a creare anche solo un cortometraggio, ci pare di aver compiuto una miracolosa opera d’arte. Proviamo così a lasciare traccia dei luoghi che attraversiamo, per non disintegrare il percorso compiuto e, con esso, noi stessi.